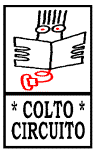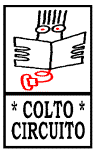|
L’Associazione
Nazionale Umoristi
propone
ai perditempo talentosi:
Endecasillabare,
puoi tu pure!
|
L’endecasillabo
è il verso per eccellenza, nobilita ogni argomento, leggero
o ponderoso che sia. L’idea è quella di creare un grande,
tumultuoso accumulo di endecasillabi, che possa, prima o
poi, costituire un apocrifo poema a zigzag - cosiddetto
per il continuo cambio d’argomento - che gareggi almeno
per quantità con la Divina Commedia.
Se
sai creare versi endecasillabi in rima,
sei invitato a inviarceli
ogni volta che ti vien voglia.
Qualunque
argomento è adeguato. Qualunque quantità è acconcia, a partire
da due versi. E’ richiesta la rima, a tutti i costi.
Non è data una scadenza per l’invio dei tuoi endecasillabi:
d’ora in poi, una o più più più più volte, il poema
apocrifo a zigzag attende le tue piccole o grandi creazioni,
fino alla fine dei tempi. I tuoi versi, senza titolo e senza
indicazione del tuo nome, saranno inseriti di seguito a
quelli esistenti, che trovi di seguito. Questo sito sarà
continuamente aggiornato, ogni volta che avremo ricevuto
un non esiguo quantitativo di nuovi
versi.
Spedisci
i tuoi endecasillabi a:
umoristi@tiscalinet.it
Il
poema è titolato: “LAVERDURE”,
nome
di un pappagallo narrato da Raymond Queneau, il quale pennuto
sapeva solo gracchiare la frase: “Chiacchieri, chiaccheri,
non sai far altro”. Vabbé, ecco qui di seguito i versi
finora pervenuti.
|
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
“LAVERDURE”
Poema
apocrifo a zigzag multiconferito da tot autori… voi compresi?
"Di nostra vita a mezzo del
cammino
in una selva oscura mi trovai,
ch'aveo la dritta via smarrito e mai
sapreste immaginar mio rio destino."
Se l'Alighieri avesse principiato
così la sua Comedia, poco o nulla,
sua opera Divina avria cangiato,
ché sempre endecasillabe trastulla
le rime, che - con l'undici battute
sillabiche - di fino son vestute!
Perché l'endecasillabo è sovrano
fra tutti i versi, va sano e lontano.
L'istesso vien richiesto a te che leggi:
endecasillabare insieme a noi,
endecasillabare quel che vuoi,
endecasillabare finché reggi.
Ma poi, tu la conosci la Comedia
di cui s'è detto, di Dante Alighieri?
Forse è vecchiotta, ma vi si rimedia
facendo dei ritocchi veritieri,
che meglio sono adatti ai nostri giorni.
Ora ti facciam tosto qualche esempio,
mettendo a parte timidezze e scorni
e pentimenti per cotanto scempio!
Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura,
ché la diritta via era smarrita.
Per render la faccenda meno dura,
presi a tagliarmi l’unghie delle dita
ed i peli nel naso, con gran cura.
Ma venne un rompipalle sui miei passi
e volle che all’inferno con lui andassi.
O muse, o alto ingegno, or m’aiutate;
o mente che scrivesti ciò ch’io vidi,
qui si parrà la tua nobilitade.
Poeti e santi davan nostri lidi,
e pur navigatori… Non corsari,
né faccendieri, né presentatori,
né vannemarchi, né palazzinari.
E’ il buco dell’ozono, miei signori,
che ha la colpa di tutto, garantito.
L’ha scritto un quotidiano di partito!
“Per me si va nella città dolente,
per me si va nell’eterno dolore,
per me si va tra la perduta gente.”
Questo era scritto sopra lo settore
che i tifosi interisti mestamente
stivava, con sul volto gran pallore.
Avevan freddo, ma faceva caldo,
perché non li copriva il rio Ronaldo!
“Vuolsi così colà dove si puote
ciò che si vuole e più non dimandare.”
Vabbé ho capito, non potrò carote,
ma solo bastonate rimediare,
come la palla ch’è picchiata al volo
da quei che fanno un giuoco detto “polo”.
Amor che a nullo amato amar perdona,
mi prese del costui piacer sì forte
che, come vedi, ancor non m’abbandona,
pur se m’attocca molto trista sorte!
Potessimo, in un’orrida una stanzetta
viver di stenti fino ad ottant’anni:
macché mi tocca, con ‘sto barbagianni,
tirar le cuoia nel lusso e in tutta fretta.
Questi, che mai da me non fia diviso,
la bocca mi basciò tutta tremante…
Basciò, capisci?! Non baciò il mio viso,
basciò: sbavava come un elefante!!
Ci misi sette giorni ad asciugarmi
e d’essere bagnata ancora parmi!!
Mentre che l’uno spirto questo disse,
l’altro piangeva, sì che di pietade
io venni men così com’io morisse
e caddi come corpo morto cade.
Dopo tre ore venne l’ambulanza;
pel traffico giungemmo all’ospedale
quattr’ ore dopo. Ciò non fu abbastanza,
costommi la barella un capitale!
Quando ci scorse Cerbero, il gran vermo,
la bocca aperse e mostrocci le zanne.
Ma passava un dentista e disse: “Fermo!
Hai trentanove carie alte due spanne.
Veni al meo studio prima del tramonto,
te le tappo con stoppa e ti fo sconto.
“Pape satàn pape satàn aleppe!”
cominciò Pluto con la voce chioccia.
Quando che Topolino lo riseppe,
disse: “ Sei sbronzo per una bisboccia?”
“No.” disse Pippo “Lo tuo cane è scemo:
crede sia un motivetto di Sanremo.”
In la palude va ch’ha nome Stige
questo triste ruscel, quand'è disceso
al piè delle maligne piagge grige.
Ciò nonostante un ombrellone è preso
per euro trenta, le due sedie a sdraio
per euro ottanta ed un gelato, un paio.
Ed el mi disse: “Volgiti, che fai?!
Vedi là Farinata che s’è dritto,
dalla cintola in su tutto il vedrai!”
“Vederlo intero non è mio diritto?”
dissi a Virgilio. “Ma è senza mutande!
In lavatrice ce n’ha messe un paro,
domani è giorno di bucato grande.
Qui il detersivo costa molto caro.”
Fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir Virtute e Canoscenza,
che son due cameriere di Vicenza
con posteriori sodi e ben pasciuti.
Ricordo quella volta a Camaiore:
gli andammo dietro quasi per tre ore!
Non loro, ma ai suddetti posteriori,
flautanti come flauti incantatori!
La bocca sollevò dal fiero pasto
Conte Ugolino, chiuso nella cella:
più nulla a quel tapino era rimasto
da scofanare dentro la scodella.
Lanciò, pertanto, un urlo alla cucina,
plorando un altro poco di testina.
E si giustificò: “Se chieder oso,
non è per fame, ma perché ugoloso!”
Era già l’ora che volge il disio
ai navicanti e intenerisce il core.
Pertanto dissi lasso al Duca mio:
“Basta Commedia, meglio spender l’ore
con un bel film giallo. Vò tornare
alla magione, là faccio un bel bagno,
da una birretta mi fo dissetare
e davanti alla tele m’appapagno!
Oh, bada: chi fa bene per paura
non vale niente ed assai poco dura.
E sappi che il parlar senza pansare
è come lo sparar senza mirare.
Solo il denaro che vien risparmiato,
non una, ma due volte è guadagnato.
Se agisci con saggezza e con pazienza
a spese altrui raccogli conoscenza.
Chi monta dei cavalli tristi e buoni,
ricordi di spronar con gli speroni
Meglio è patir le insidie d'un nemico
piuttosto che l'invidia di un amico.
Non c'è nel mondo cosa al par peggiore
che in membra vecchie pizzicor d'amore.
Nel brodo primigenio ov’io mi sento
Legato ancor dal primigenio nodo
me vo cercando; molte strade tento
ma non ha pace e ’l cor drento mi rodo.
Tra fortuna e virtù mi libro a stento,
incerto ricercare di rapsodo…
Forse tempo verrà, forse un portento
saprà mostrar nel pelago l’approdo.
Ecco salvezza! Da virtù redento
e, quasi in forza d’arbitrale lodo
verso fortuna il debito perento,
con ratta decisione vado al sodo
e, il nappo al ciel, dò fine al mio tormento:
nunc est bibendum, primigenio brodo!
Un carrarmato con la meningite
vuole donare molle e viti avite
ad un trattore agricolo, suo amico,
che incontra ogn'anno alla Sagra del Fico.
Ma quando le scartoccia, va a scoprire
che le molle son molli e, manco a dire,
che le viti lo evitan sdegnose.
Dona al trattore i cingoli e altre cose.
T'adagio sopra l'ali dei gabbiani,
ma tu mi sfuggi, cruda: "Poi, domani...."
Ti dedico poesie, novelle e brani.
Vuoi che li legga? Niente: "Poi, domani..."
Ti cullo fra le sete dei divani,
ma tu mi tieni a bada: "Poi, domani..."
Vorrei sfiorare i tuoi bei seni ispani
tu mi rintuzzi con il: "Poi, domani..."
Son disperato, faccio sogni strani
e tu m'ignori con quel: "Poi, domani..."
Vuoi che t'uccida, dunque, che ti sbrani?!
Tu, come niente fosse: "Poi, domani..."
Ma all'improvviso, sogno o sono desto?,
t'abbandoni e comandi: "Facciam presto."
Tanto per non cambiare, ce ne siamo
fatt'uno nostro, ma pochi lo sanno.
Comincia il tre gennaio, va avanti piano,
finisce a caso: Buon Napoletanno!
Rose di seta porgi con le mani
a quei passanti rapidi e ansimanti
fra le botteghe e i treni, pochi istanti
di tregua per soldati e capitani.
Da sconosciuti prendi caramelle,
che poi disciogli nella bocca calda,
sterile grembo di una stirpe salda
nutrita dai silenzi delle stelle.
Conti monete che non puoi portare
a un banco che rilascia ricevuta,
produci merce che non vien ceduta,
solo prestata, vuoto a riciclare.
Lo maledici e il mondo si dà pace,
gli cedi il freddo del tuo manichino,
che è più lontano quanto più è vicino,
che con lo sguardo che non guarda tace.
Mi muovo dentro il letto, sono inquieto
e come sempre squilla la sirena,
mi richiama al dover, volto la schiena,
aspetto ancora un po', raccolto a feto.
Chiama un amico che soffre d'amore,
la campagna è riarsa, anco lo spirto,
ma restan dolci le bacche del mirto:
chiedi all'amaro, se cerchi calore.
Entro in ufficio, ormai porto di mare,
ove san sol lanciar gomène rotte,
come migranti serrati alle scotte
s'aggrappano alla speme di cambiare.
Mussi interroga il teschio, come Amleto,
in ginocchio a pregare un cero spento,
Maroni invece pensa al cambiamento,
c'è chi lo sconto ha tutto, agli altri il veto.
Fulgido esempio del regnar confuso,
la carta straccia dei diritti umani
serve ormai solo per nettare mani
dall'uraniche tracce o del cul buso.
In qualche modo mi devo sfogare,
non muscoli nè gònadi pulsanti
contro il fulgore di corpi arroganti!
Vado in palestra a endecasillabare.
Che vita sciocca! Lunga lunga lunga
ed un momento dopo è già finita.
Solo un momento, neanche che si giunga
a terminare l’unica partita.
Sesso sovrano semina sussurri
su serici sentieri serpeggianti
scolpisce seni sodi scoppiettanti
sazio si stende su sofà silenti
sale superbo scale scricchiolanti
scovando sogni stinti, segni spenti
scende sconfitto, senza sentimenti
stupito solfeggiando sibilanti
suoni sinuosi, salmi salmodianti
sardonici sonetti saltellanti.
Mattina che s'affaccia al davanzale,
che lustra puntigliosa le facciate
di cascine ciarlanti sul canale
e sparge nuvolette spensierate.
Mi dite quale spirito esiziale
possa aver scritto queste cavolate?!
Con le parole, quando vuoi, ti scopri
ed anche ti nascondi, al tempo stesso.
Con le parole fai l'arrosto e il lesso,
batti la fiacca quanto più t'adopri.
Parole grasse e secche, lievi e grevi,
che danno da campare e danno stenti,
rimbombano nel capo e non le senti,
ti fan digiuno mentre mangi e bevi.
"Alorap" è "parola" all'incontrario:
vivono insieme, l'una dentro l'altra.
Perché la vita è sciocca quanto è scaltra,
mentre va in scena, tira giù il sipario.
Come una bolla soavemente danzo:
son fatto di poliuretano espanso.
Cala la notte, come le mutande
d'una fringuella facile d'umore,
cala come il solerte squartatore
cala la lama e le budella spande.
La notte cala... ma chi se ne cale
se non i piedipiatti ed i guardiani?!
Cala la notte sopra ignavi umani,
cala occhieggiando per dirute scale.
Mi chiederete perché tutto questo
cianciare senza scopo e contenuto.
Fors'avete ragione, vi saluto
e faccio un passo indietro, un passo mesto.
Volevo solo dire che la notte......
ma vedo che nessuno se ne fotte!
Amore al tossicchiar d'una ciabatta
senza promesse di frutti proibiti
qualche festività con i canditi
folli avventure per un can che gratta.
Ricordi al sugo di naftalina
serbati in fondo al vecchio portafoglio
vicino al boccheggiar d'un quadrifoglio
ch'ella colse con ansia, una mattina.
Abito della festa, profumato,
capelli lustri a onor della famiglia
ch'offre liquori, pasticcini e figlia...
Non bello, ma distinto e reputato.
Sulla bilancia: qui, la promozione.
Sull'altro piatto tutto da eguagliare:
un nonno maresciallo e, a quanto pare,
un cugino imbattibile a scopone.
Niente debiti dopo il ventisette!
Ecco la campionessa del rammendo!
Io do... cosa mi date? Bene, prendo.
Un patto fra gorgògli d'anisette.
Un orologio isterico montava
venti lancette: stava esagerando?
No, quella baraonda gli garbava,
errava l'ore, un'ora non errando.
Conobbe una clessidra all'osteria,
con la scabbia alla sabbia, che tormenti!
Non vedea l'ora di filare via,
l'isterico orologio, via coi venti.
A volte è bello far la polpettina,
tonda, sugosa, quattro morsi e via.
Pagato il conto, chiude l'osteria
e si riapre all'indoman mattina.
Aemiliae, tu qui placide recubas
in domus tuae lateribus pertutis
per libros tuos oblitus mundi tubas,
aeternae simulacrum juventutis,
benevole tuos aspice sodales
qui tam laetitia accensi quam libentes
multas extruunt cenas augurales
ad temporis adventum attendentes.
Dicamus bona verba: dies natalis
qui venit inter nos tamquam nubecula
incendit corda, tam cum grano salis.
Tametsi eripis te sicut vulpecula
Accipe sonum vocis amicalis:
"nyn chrè methysthen": vale Aemilie in saecula!
Cosa vuoi che ti dica "Trullallà"?
Oppure vuoi che faccia piroette?
O forse "Dolce dama, mi permette..."?
Ma cosa? Tu, neh, dici.... Mah chissà.
Conosco un navigante che non torna,
un sarto che non cuce più un vestito,
un saltimbanco mìsero e imbolsito,
una puttana vecchia che s'adorna.
Non te ne frega niente? Cosa importa,
perchè quella che conta è la poesia,
le rime sono lampi di magìa,
il verso scorre ed apre la tua porta.
Ora faccio sul serio: cuore? Amore!
Nemico? Amico! T'odio. Simpatia....
Ora ti dico il vero. O la bugìa.
Son cinico o m'inebrio di stupore!
Trovi scolpito sopra la mia soglia:
"La strada dell'eccesso va al palazzo
della saggezza". Sono savio e pazzo,
mi so privare e brucio dalla voglia.
Sto concludendo, pochi versi ancora,
non so, potrei riempirli di parole
o di silenzi rumorosi. Vuole
dirti la penna.... nulla, mia signora.
Gianromolo Sorcagno, patrizio di Peluria,
ama la mortadella, la pàprika e l'anguria,
ama le cameriere castane di capelli,
ama i libri di Busi e i film di Monicelli.
Gianromolo Sorcagno patrizio di Peluria:
è questa la sua vita stremata di lussuria.
La cerbottana è uno strumento antico,
vuoto di dentro, fuori riflessivo.
Non legge, ma conosce un transitivo
o un congiuntivo o un motto assai pudico.
La cerbottana non paga le tasse,
passa di bocca in bocca, è chiacchierata.
La cerbottana un giorno l'ho invitata
a bere birra, quattro o cinque casse.
Armando mio tu sei come il barone
che nel rumanzo di Madam Luciè
scappa colla signora Margarè,
moglia der conte di Castellumbrone.
Bello, colle basette fino ar mento,
tiene il capello colla brillantina
e quer vestito che c'era in vetrina
in quer negozzio presso al reggimento.
E' in quella dorce notte di peccato
che lui beve tre coppe di sciampagna,
poi piglia la signora e l'accumpagna
drento al ciardino tutto prefumato.
E la bacia, Armandino! Tale e quale
di quella vorta che ci annascundemmo
dietro alla barracchella di zio Memmo,
con passiona, alla Villa Cumunale!
Non era un testa a testa, io e te:
ci steva pure quell'amica mia
assieme al fidanzato. Fanteria.
Tu però eri il barone, io Margarè!
Il giorno è poco, serve per campare.
La vita esplode quando si fa notte!
Poi, la tenebra sfuma in un sussurro...
Io m'alzo spento e mangio pane e burro.
Facciamo com'io fussi un cavaliero
e che tu fussi virgine a le rocce,
desnudata de' panni e co' le pocce
e co' le gratie tue sanza mistero,
renserrata et avvinta de catene...
Il monstro! Ecco che sguizza da lo flutto,
che già s'avventa, ma lo infilzo tutto
a la mia spada! E che tu me voi bene.
Il mondo che ti sveglia ogni mattino
per darti un soldo nella mano tesa,
cammina per le strade a gamba stesa
più s’allontana, quanto più è vicino.
Noi vivemmo felici. Io ti permisi
di rammendar calzini il lunedì.
Tu non dicesti nulla quando misi
quella cravatta a righe rosse e gialle.
Non dissi niente quando il generale
volle pescar nella tua scollatura
la sua dentiera e tu non protestasti
quando mangiai cipolle sul comò.
Cospargesti i miei occhiali con la pece
e non osai di profferir parola.
Anche quando fuggisti con Gondrano
non vi fu screzio per il nostro amore.
Eppure il dramma esplose con violenza,
tanto che m'impiccai con una stringa,
quando (ricordi, cruda?!) non volesti
ch'io ti mettessi a mollo nel vetriolo.
Sono spiacente, chiudo l'uscio e vado,
vi lascio il mio cappello grigio floscio,
non dico nulla, che sennò v'angoscio,
se non mi salutate, non ci bado.
Coprite quelle scritte sopra i muri.
Ah, per natale manderò gli auguri.
Un bivio ambiguo, ad una sola via,
stava davanti a un verme solitario,
che sferragliava su una ferrovia
buona sol per andare, a un sol binario.
Per il ritorno, non si sa che dire:
si chieda ad un corsaro o a un caseificio
o a un bonzo o ad un fuochista d'artificio
o a un oste che non sa cosa imbandire.
Non dite che non sono stato ai patti,
ho fatto quanto basta per campare.
E ora, arrivederci, ci ho da fare,
devo tornare dentro, là fra i matti.
La nave resta in secca senza il mare,
il vento asciuga il sangue nelle vene,
non arde il sole senza il kerosene...
Andate e non tornate, ci ho da fare.
Nel mezzo del cammin della sua vita,
un tale andava per la selva oscura,
perché quel bischerone avea smarrita
la sua lanterna, oltre la via sicura.
Un grullo, che volete che vi dica?!
Avea scordato pure il cellulare
e le carte stradali e la mollica
che Pollicino usava per tornare.
Per dare un tono alla sua tremarella,
scrisse dei versi su quell’infernale
marasma che torceva le budella
come una purga grossa, da un quintale.
Alfin la smise e venne il paradiso
per quei che i suoi versacci sbrindellati
dovean ingurgitarli e far buon viso,
sennò agli esami l’erano bocciati.
Colombo, Michelangelo, Leonardo
e ancora tanti altri capoccioni
han fatto il 400, ma uno sguardo
speciale va a un tipetto coi marroni.
E’ Gutenberg, il crucco che ha innescato
una rivoluzione senza pari.
Non lo sapete? Diamine, ha inventato
la stampa a tipi mobili, compari!
Quella che ha consentito l’istruzione
delle masse ignoranti e contadine,
quella che ha dato tanta diffusione,
coi libri, a idee virtuose o libertine!
Noi oggi abbiam guastato quest’incanto
con uno scatolone delirante….
sì la televisione, che da tanto
sputacchia cose sciocche, tante e tante!
Veniamo al 500. Buonarroti
è ancor protagonista. Ma c’è un tale
un inglesino schivo, che dà ai moti
dell’anima un respiro universale.
Si chiamava Guglielmo e, gratiae deo,
tifava per Giulietta e per Romeo.
“600” se lo dici ad un pisquano,
risponde: “La vettura utilitaria
dell’avvocato Agnelli?” oppure varia
con un “Non ho monete nella mano…
Se vuole, posso darle mille lire.”
Voi, invece, avete certo già compreso
ciò che con pochi cenni voglio dire:
sto parlando del secolo a cui peso
han dato il pendolare Galileo
e Rembrandt, maestro delle tele,
e il Re Sole e quell’altro cicisbeo
di Newton, che giocava con le mele.
A volte raccontar la storia vera
è proprio una solenne seccatura.
è una muffosa e stinta tiritera
per la gente passata e la futura.
Allora vi dirò, miei cari amici,
ciò che nel Settecento non fu fatto:
non c’eran videogiochi e lavatrici,
non c’era il cibo in scatola pel gatto,
non c’erano i carciofi surgelati,
né quei telefonini cellulari
che se ritrovo quel che li ha inventati,
lo picchio nei dì dispari e nei pari!
Non c’erano i tormenti d’oggigiorno,
avevano altre gatte da pelare,
come quel Robespierre che andava intorno
e aveva in testa teste da tagliare.
Ma ci pensate? "Secolo" è maschile,
finisce con la “o” grassoccia e greve!
Per una volta, usiamo il femminile:
la “secola” ha più grazia ed è più lieve.
Dovrei introdurvi, dunque, all’Ottocento,
la secola di Verdi e Carlo Alberto,
ma pure di colei, qual piuma al vento,
mobile… ma che tipo? C’è un esperto?
Era costei una madia o un canterano?
Era una calatoia o un comodino?
Era un armadio a muro od un divano?
Era una cassapanca od un fratino?
Nel millenovecentodiciannove,
vestito di vual e di sciffòn,
io l’ho incontrato e mi ricordo dove:
comprava borse da Lui Uittòn!
Lo sciocco sperperava il mio stipendio
per una griffe: dite, ma si può?!
Alla boutique ci appiccai l’incendio,
quello non fè una piega. E dove andò?
Di fianco c’era una profumeria
e quello si rimise a sperperar!
Lanciai una bomba, per tirarlo via,
perché tornasse al nostro casolar.
A casa, lui distrusse i miei balocchi
per vendicarsi, il turpe gigolò.
Di pianto si riempirono i miei occhi,
non vidi un tubo e caddi sul comò.
Che ci trovai? Mannaggia, tre civette:
checcazzo ci facevano lassù?!
Facevano all’amore le troiette,
in quel casino infame, dimmi tu!
L’amore con tre maschi? No, di certo:
solo con uno, il figlio del dottor!
Almeno il fesso fosse stato esperto,
invece era una frana, uno squallor.
Prendeva tonnellate di viagra,
ma il suo… morale rimaneva giù.
Vabbè, finisco qui l’indegna sagra
e me ne torno nella mia Viggiù,
a rimediar pompieri fannulloni,
solo capaci di infiammare i cuor,
ma almeno non ti ciulano i soldoni,
né gli orecchini, né i monili d’or.
Dicono che il domani è virtuale...
ma che vuol dire, che più non si tocca?
Come potremo far le tagliatelle?
E i bimbi? Basta con il ciuccio in bocca?
E ai semafori, poi? Quel dito al naso
che ci accomuna tutti, noi italiani?
Sto virtuale, se ci fate caso,
è una gran fregatura pel domani!
Come faranno Biagio e Filomena
a coccolarsi nella camporella?
E a me, che piace intinger nella crema
il pollicione? Che farò, flanella?
Forse verranno da lontani mondi,
con astronavi lucide e rombanti,
dei tipi buffi, ma più assai profondi
di noi, navigator, poeti e santi.
E ci faran capire il nostro errore,
che abbiam confuso con i fiaschi i fischi.
Domani virtuale? Nossignore,
non ci conviene, ci son troppi rischi.
“E che domani, allora?” chiederemo
a quei tipetti con in testa un coso
che pare un frullatore. Ci diranno:
"Non virtuale, gente, ma virtuoso."
La grappa cola rude alle budella
ove s'ingentilisce e conviviale
s'intriga con il manzo, col maiale,
col mascarpone e colla mozzarella.
Poi s'alza fumigando e neghittosa
va del cervello fino a la magione,
colà s'addensa in torrida emozione
e al tempo stesso in pace comatosa.
Questa è la rude grappa, se la intendi,
dal mondo avaro nulla in più pretendi
e se qualcuno intorno frulla e scappa,
rinsaldati aggrappandoti alla grappa.
Chi vuole, sappia: chiedo a questa vita
disinteresse allegro e contagioso,
un letto per godere un buon riposo
e la diritta via, che ho già smarrita.
E basta con i versi lacerati,
con rime marinate nel limone,
coi drammi a pranzo, a cena e a colazione,
col “meglio essere male accompagnati”.
Ci son modi diversi per parlare
al cuore della gente e alle budella
che reclamano amore e mortadella,
sirene e cozze putride di mare.
Basta: parola magica ed inane,
fine e principio, porta che si chiude
o che sta per aprirsi, che ti illude
e ti delude, se sei preda e cane.
Ho detto “basta”, ma mi son pentito.
Non vale dettar norme alla poesia.
La foglia é larga, stretta é già la via
che mena al dubbio stento e rinsecchito.
L’inutile pensiero é come il pane
che intingi dentro il sugo della vita.
Ti svuoti, e la giornata é già finita,
ti resta dentro un gracidìo di rane.
Magnaveme resate e panzarotti
quann’eveme uagliune, e so’ tant’anni.
Mò nuie ce revedimm cu’ ati panni,
ammappuciati e nu’ tantill rutti.
Ma rind a ‘nnuie, e nun o’ sann ll’ate,
so ancora panzarotti e so’ resate.
Mangiavamo risate e panzarotti
quand’eravamo giovani (tant’anni!).
Ora ci rivediam con altri panni,
son stazzonati ed un tantino rotti.
Ma dentro noi (voialtri l’ignorate)
restano i panzarotti e le risate.
Grandi parole, piccoli pensieri,
sedie di paglia scrocchiano i sederi,
parliamo solamente per parlare,
solo il silenzio resta ad ascoltare.
Ballate, il tempo è musica e la vita
son le parole, comiche o struggenti,
è meglio che la danza sia eseguita
con sensi svegli e ottenebrate menti.
Finito il ballo, tutti alla stazione
ad aspettare il treno della sera,
lì siete viaggiatori, non persone
e il tempo è una nojosa tiritera.
“Chissà se torneranno i tempi belli,
se rivedremo il cielo senza fumi
e il fiume senza concia delle pelli
e la campagna sgombra dai lordumi
e le borgate parche di rumori,
e gente sorridente, rispettosa....
Da quando son venuti quei di fuori,
mi piange il cuore, ma è tutt’altra cosa!”
Così si lamentava Romoletto
de Roma, ch’era ancor caput mundi,
ma ancor per poco, perché s’era stretto
l’assedio d’Ostrogoti e di Burgundi.
E’ storia vecchia, trita e ripetuta:
si stava meglio prima, non adesso.
Voi mi direte: é solo una battuta!
Io vi rispondo: None, l’uomo è fesso.
Domani i nostri figli piangeranno
il nostro cielo, pur se sbrindellato,
e il mare intorpidito dal malanno
dell’olio e della schiuma del bucato.
Magari studieran che la preistoria
non s’è conclusa con l’Era Neolitica,
bensì con quell’impero della scoria
che prese il nome d’ Era Catalitica!
Un’era dove non soltanto il cielo
era di piombo, ma pure il cervello,
greve di nulla, torpido pel velo
del telequizzo e del telenovello.
Né l’ossidocarbonio, né il liquame
fanno l’inquinamento più marrano.
Che sia piuttosto il corruttore infame
quello che noi chiamiam “genere umano”?
Ma c’é speranza. L’umorismo, forse,
può farci sollevare quel culetto,
di piombo anch’esso, dalle ottuse morse
in cui l’abbiamo posito e costretto.
Se diamo l’ali a cuore e fantasia
come farfalle noi svolazzeremo
sopra il cemento, sopra la follìa,
e sopra il festivallo di Sanremo!
Avanti il tamburino, poi la truppa,
che marcia canticchiando all’obitorio,
credendo che sia invece il refettorio
caldo dei fumi dell’amata zuppa.
Marciano lieti verso triste sorte,
l’uno che fa fracasso coi bastoni,
l’altri che se ne vanno buoni buoni
ben imbrancati nelle aperte porte.
Vengono dietro con le salmerie
i carri traboccanti di puttane,
c’é qualche verità fra le sottane
ed i merletti delle biancherie.
Prima di dire ciao, fra gambe schiuse
si tuffa l’innocente fantaccino,
prende il piacere, poi va al suo destino
che non conosce, verso mete illuse.
Il tamburino batte il tempo, truce,
ed ogni colpo decima la truppa:
nell’aria aleggia grasso odor di zuppa,
pria tacciono i romori, poi la luce.
Contratterò due gocce d’allegria
da un ceffo che la spaccia sui cantoni,
una risata e fuori dai coglioni,
al braccio della zia Malinconia.
Ma poi, chi ve l’ha detto che la piva
é segno d’un umore terra terra?
Mi sento come un prence d’Inghilterra,
ma senza nave, fermo sulla riva.
Son ricco come un oste annacquatore,
però i quattrini già li ho sperperati.
Son libero d’andare per i prati,
turando bene il naso pel fetore.
Qui ci vuole una chiusa che ammonisca,
che lasci il segno sulla pelle dura
di quei mufloni tronfi sull’altura.
Ma non mi viene, meglio che finisca.
Faccio la notte a pezzi, poi la incarto
e la regalo a chi non la conosce,
a chi non vive le pacate angosce
confezionate da un crudele sarto,
che cuce carne e trine, che drappeggia
un broccato prezioso e una scorreggia.
La grande vulva rossa popolana
accoglie capitani e marinai
sull’orlo della sera, quando stai
di fronte al mare e all’isola lontana.
Volgi le spalle all’epopea carnale
che si consuma fra le mura tristi
di luce fioca. Mentre tu rovisti
nei sogni, la marea muggendo sale.
La strada non aspetta, si allontana
fra case e muri, in cerca d’occasioni,
é una bagascia arguta, una puttana
che gode soprattutto coi birboni.
Stende cenci di cielo, li nasconde,
cammina a testa bassa bofonchiando,
la strada é dove e come, cosa e quando,
se chiedi dove va, non ti risponde.
La strada é una ferita della terra,
che spinge armate pronte per la guerra.
Far poco o niente ed aspettar che venga
qualcuno a presentare l’ingiunzione,
dare una rimestata al minestrone,
l’aria distratta, non c’é “ma” che tenga.
Restare alla finestra e fare cenni
a chi cammina ancora a testa alta,
accatastar mattoni senza malta,
tenere come motto: “Vidi e venni”.
Contar le pecorelle e restar sveglio
per disegnare fole sul soffitto,
scrivere tutto ciò che non é scritto,
pensare solo al peggio e non al meglio.
Prendere un libro, non importa quale,
leggere le parole alla rinfusa,
riporlo nel cassetto e, a scena chiusa,
interpretar la comica finale.
Il verso spento non é più poesia,
é un bacio della zia malinconia.
Fra le navate d’una antica chiesa
perdere il senso dell’orientamento
e poi scovare una parola accesa
fra l’ombre cupe dell’ammonimento
che un preticello steccoluto e nero
scaraventa dal pulpito grifagno.
E infine ritrovare quel sentiero
da battere senz’ombra di compagno.
Frattaglie di racconti, versi astiosi,
morali raccattate, bozzettini,
passioni smozzicate, zuccherini,
pensieri che s’ammucchiano accidiosi.
C’é una piazza a Siviglia e una panchina
caramellata con le mattonelle,
passano altrove chierici e zitelle,
io me ne sto seduto a far manfrina.
La piazza é una ciambella, sto nel buco,
qua e là fiorisce il sole e me lo bruco.
Guardo il soffitto e cerco ispirazione,
un verso che racconti in qualche istante
una totale assenza di emozione,
la mente sgombra, l’anima esitante.
Gocciola nel silenzio della notte
un simulacro di pensiero liso,
resti di gioventù, parole rotte,
una risata stinta e ancora un viso
che non ricordo più, ma che vorrei
vagasse altrove che negli occhi miei.
Sai quando sento d'essere più solo?
Quando ripenso a ciò che non ti ho detto.
Ora mi rode l'ansia del mio letto
e mi tormenta l'uggia del lenzuolo.
Han fatto tutto, tutto é stato detto,
tutto stracotto, tutto masticato,
tutto spremuto, tutto distillato,
tutto stivato a secco o nel guazzetto.
Però il silenzio, quello é sempre nuovo,
dopo un singhiozzo, dopo una risata,
che se ne va da solo o in adunata,
che me lo cerco dentro e non lo trovo.
Nascono nel silenzio le parole
che fanno fresca l’acqua, caldo il sole.
Io cerco chi mi aiuta a ricordare.
Il tempo é mare, sbriciola gli scogli
della memoria, dopo, togli e togli,
rimane solo il vento a vaneggiare.
Era piccolo o grande, biondo o bruno
e gli occhi: chiari o scuri? Non ricordo.
Il tempo è vecchio, dispettoso e sordo
e non risponde a nulla ed a nessuno.
Io cerco chi mi dice cosa ha fatto,
cosa ha sognato, quando ha detto basta.
Il tempo è monte, tutti ci sovrasta,
da sole, cielo e nuvole è distratto.
Nascondo i miei ricordi in una tasca
d’un pantalone liso e stazzonato,
ma il tempo è ladro, non c’è alcun che nasca
che non ne venga spesso derubato.
Qui siamo in molti per testimoniare
ciascuno una parola, un fatto, un gesto,
così freghiamo il tempo disonesto
e ci aiutiamo a non dimenticare.
Non ritornar sull’ombre dei tuoi passi,
ci troveresti solo nudi sassi.
Anco si nun mme fili, sei la meglia,
la ppiù ciaciona, la ppiù ciancicosa,
tu sei l’amatriciana sfrigolosa,
la sartimbocca carda ne la teglia.
Anco si nun me fili, ne’ miei sonni
te faccio cose che fanno arrossire
le più impunite. Te lo devo dire
che so’ preso in tonnara ppiù dei tonni?
Anco si nno mme voi, nun poi fa molto:
me so’ infilato sotto le sottane
e dovunque te movi, co ste mane
te fraccico, te sbullo e te rivolto.
So’ pappa e ciccia co’na fattucchiera
che m’ha ddato na formula co’ i fiocchi:
prova a guardarme fisso dentro gli occhi
e ‘cce vedrai pirumpe e pirimpera.
Stasera dentro ar letto facce caso
mentre t’addormi: cardo, dentro ar core
te sembrerà d’averce un friccicore
e un dito che te sfrùgola sur naso...
E ll’hai capito! Certo che so’ io,
che t’affringuello tutta e tu ce stai.
Vabbè, na vorta sola, ma vedrai
quanto te riempie questo ben de ddio!
E ppoi domani, quanno ce vedemo,
tu me dici sortanto "M’è piaciuto."
Io nun responno, me ne resto muto,
anzi te guardo coll’occhietto scemo,
perchè capisco che l'avemo fatto
ar sono de tamburi e de fanfare.
Tu già me pari che lo voi rifare...
er core che me batte come un matto!
Quann’è ddestíno, nun ce poi fà gnente:
si scappi, se rivortano li piedi,
si te nasconnì l’occhi, tu me vedi,
sì ddici no, nemmanco te se sente.
E allora, stacce! Pecchè fai fatica
e giri ‘ntorno e sempre ce ricaschi?
Fatte capace: mmezzo a tanti maschi,
sei tu ch’hai scerto, cosa voi che dica?
La morte t’accompagna per la mano
lungo la vita, che cammina lenta.
La morte é tuono, tigre che s’avventa,
onda che spazza piume di gabbiano.
La morte t’accompagna per la mano
fino a un sedile che t’aspetta muto.
La morte ti concede un sol saluto,
un cenno con la testa, da lontano.
La sogliola limanda a quel paese
e il tordo sordo sardo li stordisce,
quelli che, come te (chi li capisce?!),
non vogliono tornare a fine mese.
Torna, sennò la fregola mi frega
e il cane nel canestro, ahimé, guaisce:
i tipi come te (chi li capisce?!),
pregano pur se fan la messa in piega!
Torna, sennò il notajo nota che manchi,
manco che senza te non si vivesse,
torna perché mi oblige la noblesse,
ritorna pur se rantoli ed arranchi.
Cala la tela sulla mala mela
che sopra il molo d’Imola hai immolato:
diamogli un morso a quel tòrsolo ingrato
e torna, sennò spengo la candela.
I tipi come te, se ci fai caso,
casa non hanno, casomai un casale.
Torna, sennò la torta mi va a male.
Non far torto alla torta, è sadomaso!
Torna! Una terna ghiotta d’occasioni
t’aspetta e pur ti spetta il nonno inane:
tiriamo, orsù, a campar, come campane
che in fosse fesse suonan fessi suoni.
Ma bada, se non torni, il tornio lascio
e lascio il liscio, perché mi sfinisce.
I tipi come te (chi li capisce?!)
mòndano il mondo o il mandano allo sfascio!
Linee vibranti d'anima e di luce,
unghie di drago temperate al fuoco...
Intridere di grande quel che è poco:
gesto sapiente, che all'idea conduce.
Intuizioni, soste, rapimenti.
Valve socchiuse, labbra di conchiglia
evanescente, mentre il mare impiglia
rivoleggiando sabbie ribollenti.
Ombre sensuali di corposi impasti,
nuvole di colori meditati,
esitanti ricordi e mille fiati
spesi sui monti, sulle pene e i fasti.
Il verso non può dire che un nonnulla,
ma è amico, come un viso di fanciulla.
La piccola lanterna sopra il colle
ondeggia mite, guida passi lenti,
finché la vedi chiara, dentro senti
il gorgoglìo del tempo che ribolle.
L’occhio del cielo si rivolge altrove
quando un artista varca le sue soglie,
solo si sente un crepitar di foglie
e il ridacchiar del vento che le muove.
Se voi vendete l’anima al mercato,
andate dritti dritti in paradiso
o giù all’inferno,ma con un sorriso
di grande marca, liscio profumato.
Se dividete tavola ed alcova
con la baldracca più desiderata,
vi guadagnate bene la giornata
e avete ogn’ora una coscienza nuova.
Ma guai se ricercate la morale
in fondo ad ogni storia o se vi date
al fervido rovello: rimediate
solo un'acciuga e pan quaresimale.
Sento crocchiar la ruota sulla strada,
non me ne frega un fico dove vada,
sento tonfare passi sul selciato,
non me ne frega un fico chi é passato,
sento lontano un gemito d’amore,
non me ne.... no, mi viene il batticuore.
Porre gli accenti pel verso giusto
è un sorpassato metòdo frusto.
Fare o non fare come fan tutti?
E' questo il dìlemma che ci ha distrutti!
Prendiamo “fégato”: niuna parola
gli fa la rima.... Ciò ci sconsòla!
Fosse “fegàto” saremmo salvi,
corvini e càstani, ricciuti e calvi!
Esser diversi costa parecchio,
é un insolubile pròblema vecchio:
òrsu, si cambi, si rinnovelli,
si mondi il mondo dai mille orpelli!
La nostra mano volti pàgina,
nuova è la sera, non la mattina.
Ci sorge il fùturo dietro le spalle,
davanti alucciano nere farfalle.
Siam vecchi e giovani a un tempo solo,
della matassa siamo il bandòlo.
Bìzzarro verso, tu canti male:
ci aspetta un altro triste Natale.
Quando la mano bianca ti buffetta
sopra la spalla, mentre guardi il sole
distante del tramonto, le parole
con cui l’accogli sono una pappetta
di fole squinternate, di rimpianti
decotti, di ricordi mai accaduti,
gli chiedi ancora tempo pei saluti...
Lei ti sorride, ma ti spinge avanti.
Viaggiare su un calesse senza ruote
comprare casse vuote e scarpe strette,
contare da diciotto a diciassette,
scrivere partiture senza note,
pesare il vento ed asciugar la pioggia,
spingere le montagne verso il mare,
parlar senza parole e ritornare
a riposarsi vuoti, sulla loggia.
Seduti intorno a un tavolo a parlare
solo di quello che ci piace dire,
il resto lo lasciamo lì a dormire
come baldracche vecchie al lupanare.
Sopra le frasi belle, grattatine
di cuore e di coscienza, quei tartufi
che fan capire che non siamo stufi,
stracotti dalle birbe e le manfrine.
Seduti ad aspettare che la notte
ci prenda per l’orecchio e ci conduca
ciascuno nel profondo della buca
dove mena i rimproveri e le botte.
Ma passa. Quando bussa il nuovo giorno,
ci ritroviamo a raccontarci balle
nuove di pacca, lucide farfalle
che sbarrano la strada del ritorno.
Vola colomba, vola bianca, vola,
perché nel mondo sei rimasta sola
e noi aggrappati all’arca nel diluvio,
sferzati da un rabbioso Giovepluvio,
scampati a stento a chierici e beghine
chioccianti un miserere senza fine.
Senti, non voglio dir parole nuove,
ma vecchie tiritere mugugnanti,
rosari senza martiri né santi,
tristezza allegra che nel cuor si muove.
Ma tu non senti, non vuoi più parole,
vuoi dardi di cemento contro il sole.
Se sbeffeggiamo, voi ci condannate,
anche se conserviamo quelle cose
che son càrpite, che son cucinate,
che son vendute intere oppure in dose.
Anche se l'allegria che scodelliamo
è gran fatica, seguitiamo zitti
a tendere la mano: noi restiamo
della Commedia i brindellosi guitti!
Prendeteci, giullari nella corte,
a consumar la nostra vana sorte.
Uguale a tutti gli altri, sei diverso
come i passi del tango che scandisce
l’intelligenza armonica e distratta
dal gocciolìo dei giorni nella latta,
che lontana nell’erba arruginisce
fra sole e pioggia, fango e vento perso.
Son briciole di nulla gli accidenti
del vecchio calzolaio ch’ha perso il treno,
guizza la luna come un disco alieno
negli occhi rintanati dei perdenti.
Ruggisce la corriera, il calzolajo
ripensa al viaggio, ma non ha più voglia,
prende una margherita, se la sfoglia,
come cercare un mago in un pagliaio.
La radio spenta gracida notizie
e conti della spesa alla massaia,
che sul grembiule versa l’oliomaya,
ma non ci bada, succhia liquerizie.
Il verso suona bene, non gli occorre
né contenuto, né contenitore.
Il calzolajo ritorna al suo languore
e tace, mentre intorno il mondo scorre.
Non ve ne andate senza salutare,
lasciate una parola su un biglietto
o una foto un pò mossa o col berretto
sgrullate l’aria. Ma prima di andare
fate qualcosa, dateci un ricordo,
uno sbiadito segno del passaggio:
che sia della paura o del coraggio
non conta affatto per chi resta a bordo.
Mettete in tasca un conto stropicciato,
dateci l’illusione d’aver dato.
Allora, ve ne state un poco zitti?!
Con gli occhi freddi e con le mani in fondo
alla zuppa rovente, mentre il mondo
ozia lontano, coi capelli ritti.
E quindi date un motivetto ai passi,
per farli guazzettare nel sorbetto,
e poi strisciate truci fino al letto,
piagati da ricordi tutti sassi.
E state dietro i vetri, soddisfatti,
ad avvistare lepri fuggitive,
orgasmi astiosi persi sulle rive
di un fiume lungo cento metri esatti.
Un tavolo, una sedia, un lume acceso,
un foglio bianco che non sa che dire,
un silenzio di gesso, nudo e obeso,
una matita che non vuol dormire,
un odore di nulla, un’altra stanza
calma nell’ombra che sta appesa ai muri,
il fumo del tabacco fa una danza,
una finestra cieca per gli scuri,
un pensiero di gomma nel cervello,
quattro parole futili e graziose,
la goccia che rimbomba nel lavello,
il tempo preso ad elencare cose,
a contar morti, a stendere sudari,
ad inventar preghiere ed epitafi
per albanesi chiusi negli scafi
fatti per stare a galla sopra i mari.
Salmastre mani di costanti eredi,
corde impigliate fra formosi piedi,
dietro non odi, sopra neanche vedi,
salmastre ruote d'incostanti credi.
Gratta la neve gretta in grotte appese
sotto quel sole che rabbercia imprese
su ruvide salite non scoscese,
gotta ha l'abate, schiva maionese.
C'è un tempo per chi canta con la stizza
suoni setosi, putrida e rubizza
è l'illusione di chi scende in lizza
nell'acqua che muggisce, cola, schizza.
Sussurra il saggio armento che il pastore,
sotto la luna mandorlata, sotto
le stelle frammentate, conta l'ore
che mancano a sfornare il pane cotto.
S'io fossi piccioletto come un grillo,
m'acchiotterei nelle tue mutandine
per starti appresso e per giostrar manfrine,
pronto ad assecondarti in ogni frillo.
M'ingolferei fra i globi d'alabastro
come un ghiottone grùfola in cantina,
poi me n'andrei alla fratta porporina
a darti qualche impacco e qualche impiastro.
S'io fossi una farfalla cavolaia,
aluccerei la punta dei tuoi seni
e di quei due poponi belli pieni
m'ingollerei, cinese alla risaia.
Sopra la schiena ignuda? Ghirigori,
che solo li sa fare un gioielliere!
Colà ripasserei per ore intiere
a darci dentro, mai a venirne fuori.
S'io fossi quei ch'io sono, attenderei
che ti sgrullassi da quella melassa
che tutta t'impappina e non ti spassa...
Ah, se tu mai inverassi i sogni miei!!
Prendetevele tutte le parole,
lasciatemi gli avverbi, per favore.
Non chiederò nient’altro alle mie ore,
per dire agli altri tutto quanto c’é.
Sarò il padrone di una lingua nuova,
secca e tagliente, vanitosa e vana,
grulla come una grolla valdostana
o come una civetta sul comò.
Banale, ma la vita é una staffetta
e tu che corri con il fiato in gola
e la folla ti insulta o ti consola,
non trovi una ragione alla tua fretta
e quando passi ad altri il testimone,
non puoi veder la fine dell’agone.
A volte è saggio starsene un po’ zitti
con gli occhi pigri e con le zampe in fondo
alle tasche roventi, mentre il mondo
ozia lontano, coi capelli ritti.
E’ grullo dare ai passi un motivetto
per farli zompettare chissà dove,
per dopo accompagnarti fino al letto
con un ricordo liso e fuori piove.
E’ insano stare all’erta dietro i vetri
per avvistare lepri fuggitive,
meglio sentirsi persi sulle rive
di un fiume lungo esatti cento metri.
Ualà, l’aver mirato a quel bersaglio,
per fare centro col sinuoso maglio,
mi porta dritto ai bollettin dell’Aci,
pagati a stento dai miei nonni traci.
Confesso ch’amo i lisciator di baffi,
travetti del Catalogo Bolaffi,
che vivono di modico guadagno.
Io rido assorto, calido, grifagno,
schioccando versi autonomi e veraci,
guizzanti più del pedator Schillaci.
Veh, n’uso impropriamente li aggettivi,
anche i più ricercati, fini, rari,
per fare apologia d’aperitivi
astratti e di ghiaccioli centenari.
Chi dice che la vita é fatta a scale
e c’é chi le discende o chi le sale,
non ve la dice tutta e non gli cale
di chi solo le scende o mai le sale.
Cala la sera sopra la polpetta
fredda nel piatto, con quel poco sugo
sopravvissuto all’avido paciugo
di dita abbarbicate alla michetta.
Guazza di vino nel bicchiere stanco,
bucce di frutta a riccioli e brandelli,
tacciono le forchette ed i coltelli
sulla tovaglia, gran sudario bianco.
Il tragico è che scuci del danaro
per chiuder ‘sta bisboccia con l’amaro!
Alza le braccia al cielo con la folla
per invocare sberle dai cialtroni,
colpi di maglio dai spaccamarroni,
sorrisi lessi dai facciaditolla.
Intorno si fa il vuoto per l'afrore,
ma non importa se si è soddisfatti
delle bistecche matte che nei piatti
più che la fame, placano il furore.
Alza le braccia, sol per misurare
fin a che punto puoi tirà a campare,
con l'illusione, con il sogno trito
di titillare il cielo con un dito.
Il ponte Mirabeau, sotto ci scorre
la Senna, con i nostri amori: occorre
che io ricordi che ogni gioia piena
vien sempre dopo una cocente pena.
Cala la notte, suona un’ora e un’ora,
passano i giorni, ma io rimango ancora.
Le mani nelle mani, faccia a faccia,
sotto l’arcata delle nostre braccia,
ponte d’amore, refluisce tardi
l’onda estenuata degli eterni sguardi.
Cala la notte, suona un’ora e un’ora,
passano i giorni, ma io rimango ancora.
Come quest’acqua, se ne va l’amore,
lento perché la vita è lenta, lenta.
Ma può scorrere via con il furore
della speranza, che è tanto violenta.
Cala la notte, suona un’ora e un’ora,
passano i giorni, ma io rimango ancora.
Passano ore, giorni, settimane,
mentre il tempo non passa, qui rimane,
non tornano gli amori, questo so.
Scorre la Senna sotto il Mirabeau.
Cala la notte, suona un’ora e un’ora,
passano i giorni, ma io rimango ancora.
Peroni ha birra in corpo: così, a caldo,
direi da novecento a mille casse.
Peroni è tanto più di un fuoriclasse:
chiamatelo, da oggi, Peronaldo.
Chi gli è amico: Car-letto (se non sta,
spalmato a stracchinazzo sul sofà).
Napoli coi capelli sciolti in mare,
matrona illanguidita, che sta altrove
ad inseguire suggestioni nuove,
sopra la prora di navi corsare.
Guardiano d'ogni tempo, Pulcinella
cerca fra l'altre mille la sua stella.
Se non un ciuco, ma bensì un cavallo
avessi, di Beltade nel castallo
andrei, sordo a' richiami di Saggezza.
Direile "V'hamo". Lei, di me assai pezza,
concederebbe la sua ambita mano.
Ahimé, non ho un cavallo, ma un ronzano.
Se hai voglia di impazzire, a un cubo pensa
ch'abbia sei facce ed una al tempo stesso,
le cinque facce che non trovi adesso,
non le ritroverai manco in dispensa,
son tutte dietro quella faccia sola,
che t'occhia torva come una tagliola
(ma se t'agghiaccia, leggi pur "braciola").
Caaldo, fa un caldo ambiguo di fornace,
ma, sotto sotto, è un caldo che ti piace
perché ti squaglia con la bollicina,
più meglio assai che l'acqua idrolitina.
Non so cosa cantare, bella gente,
perciò canto la penna e il calamaio.
Oggi, la penna è ottica, un bel guaio
se è afflitta da miopia, scrivi un bel niente.
E il calamaio? Resta quel mollusco
che te lo mangi fritto all'osteria
con seppie, gamberetti e compagnia,
ti sgorghi con un litro di lambrusco.
Ci resta la matita, la meschina,
ma attenti, può scoppiare, ci ha la mina.
Gli
Dei d'Olimpo un dì, quasi per gioco,
vollero darsi al nobile certame
di ricercare ovunque - e non è poco -
chi fosse la più bella del reame.
Scesero in terra dopo un lungo volo
e, dando corpo a un certo loro piano,
scartaron Pisa, l'Africa, il Tirolo,
puntando dritti dritti su Milano.
Via la Barona, Affori, Lambrate,
l'Ortica, Porta Genova, Niguarda…
O ragazzine, cosa v'aspettate?,
Porta Romana più nessun la guarda!
Passaron su Musocco e su Bruzzano,
su Baggio, Rogoredo, Crescenzago,
poi su Fiera, Moncucco, Lampugnano,
Greco, Sempione, Turro, Macconago.
Lasciato Lorenteggio e Piazza Duomo,
scorrendo lungo Corso Porta Nuova
tutti compatti come…un solo uomo
filaron fino in fondo a Via Moscova.
Raggiunto infine il punto di riunione
ivi la santa compagnia ristette;
saliron poi con molta decisione
tutte le scale per le vie dirette.
In mezzo ai fior trovava il suo rifugio
cercando di nascondersi la bella…
Nessuno dei divini ebbe un indugio,
fu corona sul capo di Mariella.
Ragazzi cari, via quell'illusione
ché al mondo non c'è amico tanto caro
che, appena si presenti l'occasione,
non possa dirsi amico del giaguaro.
Sei la mia danza, sei la villanella
che m'ubriaca d'aria e di sorrisi
teneri, solitari e condivisi,
gioielli scintillanti, che fan bella
la mano che mi tendi ad ogni istante,
come se fosse il primo, il più esultante.
E' d'uopo fare meteoprevisione
che valga per due pasque e due natali:
mari tranquilli, piogge torrenziali,
venti spiranti da ogni direzione,
umidità alle stelle, cielo terso,
valanghe sol sui monti di ponente.
Se, poi, sono sbagliate: non fa niente,
il tempo - buon per noi - sarà diverso.
Tu, ch'ampie l'ali sciogli ad ampio volo
e l'etra sai contendere a le nubi,
il guardo pio rivolgi a me, qui, solo,
vittima e preda de' più feri incùbi.
Mia prece l'aure tua sappia ascoltare
ed il tuo nuto questo seclo arcigno
molcere sì ch'i' possa Te nomare
Amico dolce ed animal benigno.
In qual misura Tu me tenga in cale
ben dice il don che giunge di tua mano…
Qual gioia in cuor! Aspetto un giorno tale
ch'a la mia torre di San Gimignano
tu salga ansando tutte quelle scale
mentr'io mi fumo un sigaro toscano.
Viene un vascello da lontani mari,
vascia un vienello da montani lari,
monta un lascello da vontari vani,
liene un mascello… oggi, non domani.
Bimbi rognosi, sù, fate la nanna,
strilli e mazzate la balia vi molla,
per stare fermi vi spalma di colla,
se non dormite, son colpi di canna!
Fate la nanna, se vi riesce,
di pepe e ortiche è piena la culla,
non vi muovete, per un nonnulla
vi copre anche di lische di pesce.
Fate la nanna, bimbi rognosi
e cento, mille di questi riposi!
O Santa Coralìa bianca di sale,
madre dei gorghi, sposa degli scogli,
reliquie di naufragi al litorale
col tuo manto di schiuma lieve togli
e scendi dalla roccia che è il tuo trono
a intrappolar nei lacci del maestrale
chi ci deride e chi ci vuole male,
chi vuole alzarsi, ma rimane prono.
I mille posti dove andare sogno
e i cento posti dove sono stato
e dove certo non tornare agogno
e nell'attesa resto lì impalato
a snocciolare un languido rosario
come beghina innanzi a un reliquiario:
"Li troverò fra Sidney e Codogno,
oh sì, quei mille posti ch'ancor sogno!"
Occhi lucenti fra la folla spenta
e tu li cercherai fra cielo e mare,
ti bruceranno dentro, fiamma lenta,
e tu li cercherai senza cercare.
Uuuuuh, che bellezza! Friggono le reni,
colpo su colpo batton la grancassa
del ventre, poi l'inondan di melassa
e di miele e di sugo e broda e semi.
I capezzoni molli e lubricosi
li annegano la lingua sugginosa,
il bìgolo s'inarca tempestoso
e scaglia lampi dentro l'antri ascosi.
Parole mute vorrei regalarti
e occhiate calme, tenere follìe.
Ma tu sei già distratta sulla strada,
con una borsa piena di bugìe.
Pane fragrante mordo le tue labbra
nell'angolo lontano muro amico
rubi fra i seni le mie mani grosse
l'odore é una cometa tempo antico.
Racconti libri letti storie stanche
camminan negli specchi lampi azzurri
le vetrine imbottite sonno e sogni
scendi per scale ombrate di sussurri.
Lampioni raggrumati vetro freddo
strisce di sole lucido sui passi
manichini di stoppa imbambolati
sassi e parole, solamente sassi.
O cacciavite mai nessun t'ha fatto
un'ode, una canzone, una poesiola.
Io, finalmente, sì. Se ti consola,
o cacciavite, non son savio o matto,
ma sono - l'hai capito - un mattacchione
che cerca sempre nuova ispirazione.
Del genio il gene in Te, Tu Marco, porte
sì che la fatal mappa ch'è tua soma
s'illustra ne le forme sue contorte,
dono divin non semplice genoma.
Ancor, Tu sai qual gioia sia l'aprirsi
a l'arte e corrispondere a sue vaghe
illecebre, ma duro calle il girsi
guardinghi ne le asperrime sue plaghe.
Dal fondo del pantan timido gracido…
Del cor nel fondo, come su un altare
- mentr'arte e scienza Tu contempli placido -
a Te vorrei le opre mie più care,
a Te che della vita domi l'acido
Genio del gene, a Te sacrificare!
Cogliamo l'occasione di comprare
tre chili di busecche a metà prezzo.
Se non abbiamo i dindi, c'è pur mezzo
d'avere la busecche: sgraffignare
il borsellino al ciula zio Diomede,
quello che dei suoi beni mi fé erede.
Ah, se volete, c'è un'altra occasione:
di fare giusto 'sto mondo birbone.
Battendo il piè nel ritmo, ecco, la bruna
Diva scandisce il verso e 'l Musagete
indarno al monte il gregge suo raduna
già che il disìo del cor è viva sete.
Lene il suo canto, qual lucor di luna
ferma per via lo psicopompo Ermete,
dolce nepente, dondolio di cuna,
come fresc'aura scende sulle crete.
Deh canta dunque, Tu cara agli Dei.
Calliope ed Erato sieno ancelle.
Qual dolce Philomela accenti orfèi
arpeggia a' forti, e a' miti èubrie favelle
dispensa tutt'intorno, ed i tuoi bei
versi salire fa' sino alle stelle.
Le margherite tacciono nei prati,
i rospi stan tranquilli negli stagni
e noi pontifichiamo stralunati
dall'alto delle tazze, dentro ai bagni.
Donna
gentile che con occhi attenti
contempli il tuo sembiante nello specchio
mentre il pennello, coi suoi gesti lenti,
le palpebre drappeggia d'oro
vecchio:
lasciva quella mano che ti trucca,
la voce che sussurra nell'orecchio:
«Puoi mettere stasera la parrucca
dai riccioli ribelli un po' mesciati
che dà quell'aria allocca e un poco crucca
che piace a quei maschietti
un po' scafati
che adocchiano le fighe in discoteca
sperando di finire
arroventati
gemendo per l'orgasmo che gli reca
un'umida fringuella
squacquerata.
Se preferisci andare un po' alla cieca,
giocando a fare
l'oca patentata,
puoi stringere i capelli in una crocchia
mettendoti
una gonna scampanata
e fingere quell'aria un poco spocchia
di chi
non sa chi sia né cosa vuole:
vedrai d'amanti fitta una pannocchia,
sarai come la pioggia dopo il sole;
io ti consiglio invece di giocare
a fare la cartina tornasole
in modo da potere diventare,
così da risultare
vincitrice,
colei che sa il suo maschio conquistare».
«A dir la verità
sarei felice
di starmene stasera a casa mia
a mettere il tuo cazzo
in friggitrice,
ma devo andare al ballo tuttavia:
perché se non ci
andassi il deficiente
mi metterebbe il broncio: mai non sia!
Roberto
c'ha una lingua da serpente:
farebbe attorno a me tabula rasa,
avrei
un bel dir: "Non me ne frega niente"
ma posso rimaner tappata in casa?
Con un bell'harem, sì, sarebbe un sogno
avere sempre pronto chi m'intasa,
chi rapido soddisfa ogni bisogno!
Ma la realtà è diversa, bello mio,
non conta dire: "Questo lo sbologno"
se quello è un vile così fello
e rio
da far di me donzella dispregiata!»
«O sono le mie orecchie
o sono io,
mi sembri un poco troppo rintronata»
«Il verso accompagnato
con la rima
è una chimera spesso vaneggiata,
confonde spesso il fondo
con la cima,
fa andar la mente fuori carreggiata:
lo vedi? Si è sfasata
la terzina!
L'abbiamo proprio fatta la frittata!»
«Sai cosa far? Finiamo
la puntata!»
«Non trovo troppo saggia la tua idea,
mi basta solamente
rattoppare
il senso della rima alla terzina.
Dicevo che non mi piaceva
andare
stasera a quella festa da Martina,
ma rimanere in casa a trastullarmi
col corpo tuo da sera alla mattina,
usando le tue mani come armi
che
dan battaglia al corpo rattrappito:
a quell'idea mi sento già bagnarmi!»
«Signora», le rispose un po' stupito
il truccatore col pennello in
mano
«credevo lei sapesse a menadito
che piace a me di suggere il
banano,
non certo trastullarmi con la fregna
poichè lo trovo un gioco
troppo insano.
Perciò le dico, e questo me lo insegna,
che è meglio
se ne vada a quella festa
e troverà il pestello che l'impregna».
Finì
quel trucco con la mano lesta
in testa la parrucca poi le mise,
forbendo
i ricci folti in una cresta.
Guardandosi allo specchio quella rise
e disse: «Del consiglio ti ringrazio:
così per certo avrò mio corpo
sazio».
|